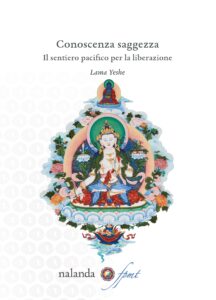Come può il nostro cuore sopportare la realtà del razzismo? – chiede Doshin Mako Voelkel? E come tratteniamo le parti di noi stessi che potrebbero voler distogliere lo sguardo?
Possano coloro che rischiano di essere minacciati o uccisi da re, ladri o furfanti, che sono turbati da centinaia di paure diverse, possano tutti quegli esseri che sono oppressi dall’avvento dei guai essere liberati da quelle centinaia di paure estremamente tremende. Possano coloro che sono picchiati, legati e torturati da legami … distratti da numerose migliaia di fatiche, che sono stati afflitti da varie paure e ansie crudeli … possano tutti essere liberati; che i picchiati siano liberati dai battitori, che i condannati siano uniti alla vita … Possano quegli esseri oppressi dalla fame e dalla sete ottenere una varietà di cibo e bevande.
Il Sutra della Luce Dorata

Questo è il nostro desiderio come praticanti. Ed è ciò che estendiamo alla sofferenza del mondo. È ciò che estendiamo alla nostra stessa sofferenza e a tutti gli esseri che soffrono. È così che teniamo dukkha.
Santikaro Bhikkhu scrive: «Nella formulazione originale del Buddha … non parlava né del “mio dukkha”, né del “tuo dukkha”. Parlava semplicemente di dukkha: “c’è dukkha”. Non c’è “mia” sofferenza, nessuna “mia patologia.” Solo dukkha, le sue cause e il percorso per alleviarlo.
Quindi le Quattro Nobili Verità non furono personalizzate in questo senso. Eppure abbiamo un modo per esteriorizzarli, poi interiorizzarli e rimanere intrappolati in quel dualismo.
Potremmo sentire parlare dell’insegnamento dell’interconnessione e forse anche dire cose come “Siamo tutti insieme in questo”. Ma non lo siamo. Ad un certo livello, sì, è vero: siamo tutti, senza eccezioni, un corpo, una realtà. Condividiamo questa vita, questo mondo, questo universo nelle dieci direzioni. Eppure, non possiamo immergerci in questa unità come se fosse l’unica realtà. Facendo così, si soccombe nella “malattia della vacuità”.

Mi è tornata in mente di recente una poesia di Mary Oliver intitolata Wild Geese. Ecco il finale:
Chiunque tu sia, non importa quanto solo, il mondo si offre alla tua immaginazione, ti chiama come le oche selvatiche, aspre ed eccitanti -annunciando più e più volte il tuo posto nella famiglia delle cose.
Di nuovo, a un livello profondo, questo è vero per tutti noi, senza eccezioni. Ognuno di noi ha i semi dentro per trovare la vera pace, per trovare la nostra bontà interiore e agio. Eppure, per alcuni, questa verità rimane drasticamente nascosta. Per Trayvon Martin, per Michael Brown, per Ahmaud Arbery, per George Floyd, per innumerevoli altri, quell’opportunità fondamentale è stata negata.
Che parte ricopro io in questo? Che ruolo giochiamo in questo? Potremmo dire, per consolarci: “Beh, non sono razzista”. Vorrei chiedere a chiunque dica quelle parole di fare un passo indietro e rivolgere l’attenzione verso l’interno.
Non ho dubbi che tutti noi abbiamo un profondo desiderio di cambiamento. Ma a volte possiamo anche rimanere intrappolati nel rimbalzare avanti e indietro tra l’indignazione e lo sconforto. Io so che lo faccio. Ci chiediamo, cosa posso fare effettivamente?
Il seme dell’agio e del risveglio, ci viene insegnato, risiede in tutti noi, ma questo non vuol dire che non ci sentiamo indignati, che non prendiamo una posizione.
Ci sono modi per rispondere a questa domanda. Come membri della società, come membri delle comunità, possiamo votare, scrivere lettere, fare donazioni a organizzazioni che si impegnano a annullare la supremazia bianca. Ci sono molte cose che possiamo fare, a cominciare dal riconoscere semplicemente che esiste un sistema discriminatorio e ingiusto che risale a centinaia di anni fa e che non è andato via solo perché è stato reso illegale.
Cominciamo da lì, riconoscendo questo sistema come ingiusto e osservando la miriade di modi in cui la discriminazione strutturale e il razzismo operano nella nostra società. Riconosciamo le pratiche discriminatorie all’interno della nostra polizia, comprese le differenze di incarcerazione, dove in qualche modo sono in prigione sei volte più uomini neri rispetto ai bianchi. Riconosciamo il fatto che le cosiddette “droghe nere” come il crack maturano sentenze cento volte più severe di quella della cocaina, anche se è la stessa droga, solo con un meccanismo di consegna diverso. Iniziamo da lì, e poi andiamo un po’ oltre e ci chiediamo, come questo sistema mi procura vantaggi?
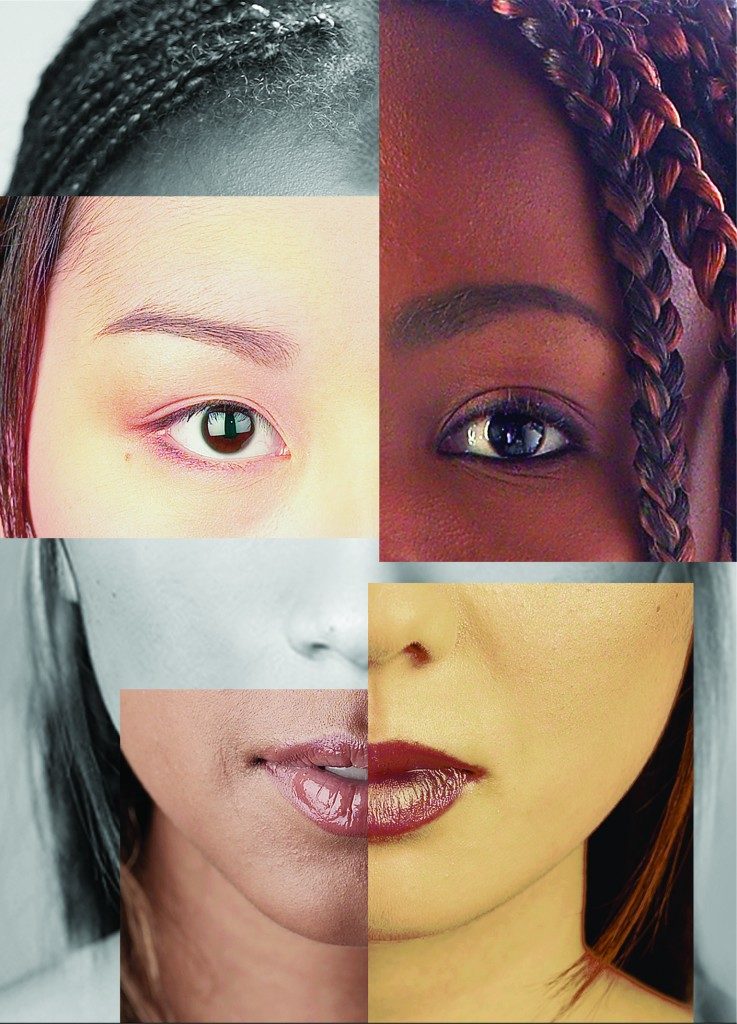
Dobbiamo anche guardare alle nostre intenzioni. Molti di noi sentono l’impulso di essere un benefattore, investiti e impegnati nell’aiutare gli altri con il loro dukkha. Santikaro Bhikkhu scrive dei benefattori dicendo: “Spesso, sono eccessivamente preoccupati per il dukkha degli altri al punto che non riescono a guardare dentro e vedere anche il dukkha che è dentro di loro”.
Quando ci separiamo, siamo in questa danza del mio dukkha e del tuo dukkha – tutti uno, eppure no. Dove ci troviamo in questa danza?
Suzuki Roshi ha parlato di come rendersi conto che “le cose sono una” sia una comprensione molto simpatetica, ma trattare le cose una per una, ciascuna in un modo diverso con la massima cura – questa è la pratica. Quando ci troviamo a scivolare dentro “Sai, è tutto uno, amico”, dobbiamo fermarci e chiedere, chi stiamo servendo? Chi sto servendo trovando sicurezza e conforto nell’unità?
In quella stessa conferenza, Suzuki Roshi ha detto:
È relativamente facile rendersi conto che le cose sono una cosa sola. È relativamente facile, o facile da accettare, sai… Anche se ti rendi conto che le cose sono una cosa sola, questa è una comprensione da kindergarten.
A meno che tu non riesca a comprendere l’idea della vacuità, non sei buddhista… Puoi vedere l’intero universo in un piccolo fiore. Se dici: “Oh, questo è il girasole che in realtà non esiste” ridendo, questa non è la nostra pratica zazen.
Come possiamo fare un passo indietro e trovare il sé che è a suo agio, non “eclissandosi di pace” o mettendo la testa nella sabbia, ma connettendoci con chi è a suo agio dentro e in mezzo al dis-agio, all’agitazione, al malcontento?
Come sviluppiamo quella capacità di stare con l’esperienza umana, che non potrebbe essere la mia esperienza in questo momento, a meno che non apriamo il nostro cuore e lasciamo entrare le grida del mondo? Il seme dell’agio e del risveglio, ci viene insegnato, risiede in tutti noi, ma questo non vuol dire che non ci sentiamo indignati, che non prendiamo una posizione, che non diciamo le cose, che non ci presentiamo in mezzo a conflitti, che non mettiamo i nostri corpi nei luoghi di protesta.
C’è un’immagine Zen del “compagno che porta il tavolo”. Puoi immaginare la sua visuale. È come un cartone animato: la persona che porta il tavolo guarda da una parte e mentre lo fa gira il tavolo, poi guarda dall’altra parte e gira il tavolo e non riesce a vedere niente dall’altra parte del tavolo.
Suzuki Roshi ha detto che quasi tutti noi portiamo un grande tavolo e non possono vedere dall’altro lato. Questo vale per me, questo vale per te. Come lo riconosciamo? C’è un grande tavolo che stiamo portando: puoi chiamarlo privilegio, puoi chiamarlo comprensione parziale, puoi chiamarlo non sapere, forse anche non voler sapere perché a volte sapere fa paura. Allora, quando proviamo paura, sentiamo l’indignazione in risposta alla sofferenza del mondo, come facciamo a fare spazio a quella parte di noi che sta gridando: “No, non va bene, deve finire?” Come possiamo non appianare questo e dire: “Oh, no, da bravo buddhista, dovrei essere in pace?” Questa è una stronzata. Penso che ognuno di noi lo sappia.
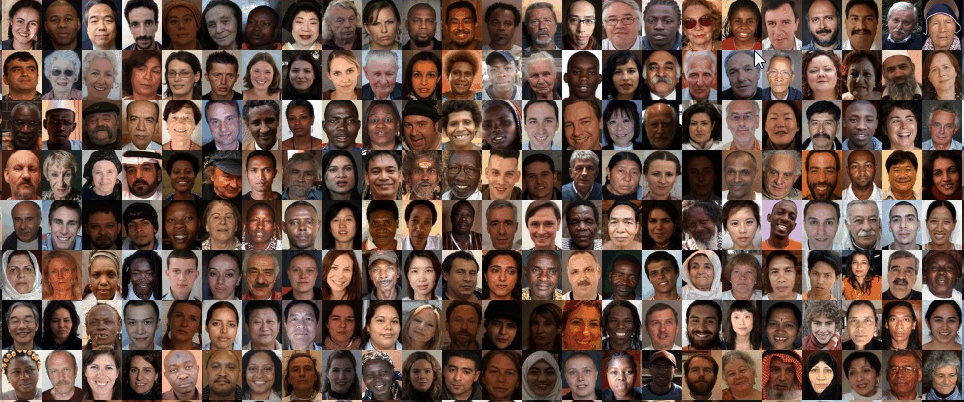
Quando parliamo di scoprire l’agio, non è che stiamo mascherando le macchie, le paure, le cosiddette “emozioni afflittive”.
Studiamo il sé perché stiamo studiando il seme dell’agio che può essere nutrito nel mezzo del dis-agio. Impariamo attraverso la pratica come fidarci nel poter sviluppare la nostra capacità di stare con la sofferenza. Questo è il nostro obiettivo numero uno come bodhisattva: essere in grado di ascoltare le grida del mondo, come Avalokiteshvara con mille braccia e gli implementi nelle mani per aiutare gli esseri sofferenti. Tutto ciò comincia riconoscendo la sofferenza.
È facile perderci in dukkha se non siamo in grado, nella nostra pratica, di consentire l’intera gamma della nostra esperienza. Se non siamo in grado di sviluppare la capacità di questo cuore di espandersi, di includere tutto, lo possiamo sentire. Possiamo sentire quando il nostro cuore è compresso. Quando il nostro stomaco è compresso, quando la nostra gola si sente compressa, lo possiamo sentire. Possiamo prestarci attenzione. Il nostro voto è di rimanere retti, in mezzo a esso, e non voltare le spalle.
Ne “La Canzone-Samadhi dello Specchio Ingioiellato, sentiamo:
Muoviti e sei intrappolato;
perdi e cadi nel dubbio e vacillante.
Voltarsi e toccare sono entrambi sbagliati
perché è come un fuoco enorme.
Ma inevitabilmente, voltiamo le spalle. Come possiamo ritornare al momento presente come parte della nostra pratica per sviluppare la spaziosità nel nostro cuore?

Gil Fronsdal, in un discorso di Dharma molti anni fa, disse questo:
“Il momento presente è affidabile: se sei presente per esso… Se non sei presente, se ti preoccupi per il futuro o sei preoccupato per il passato, forse il presente non è così affidabile. Quando siamo veramente nel momento presente, allora diciamo che “Esso risponde all’impulso di ricerca”. Se siamo presenti per questa meravigliosa realtà interconnessa della nostra esperienza presente, allora l’impulso di ricerca è presente e ciò che risponde è affidabile, anche nel mezzo di grandi difficoltà”.
Soprattutto in mezzo a grandi difficoltà, il modo per coltivare la fiducia nella nostra spaziosità, nella nostra capacità, è metterla in pratica – permettere, respirare, notare lo sforzo, accogliere la difficoltà senza giudizio e senza autocritica.
Questa è la nostra pratica. Come nutriamo lo spazio per la nostra pratica?
Quando Kishizawa Ian, il secondo insegnante di Suzuki Roshi, era un giovane monaco, era seduto in meditazione in un giorno di pioggia e sentiva il rumore di una cascata lontana. E poi sentitì il rumore aggiuntivo di qualcuno che colpisce l’Han, una tavola di legno usata per segnalare l’inizio o la fine di qualcosa al tempio.
Kishizawa Ian andò dal suo insegnante e chiese: “Qual è il luogo in cui si incontrano il rumore della pioggia, della cascata e dell’han?”
Il suo insegnante rispose: “La vera eternità scorre ancora”.
Quindi Kishizawa Ian chiese: “Cos’è questa vera eternità che scorre ancora?”
Il suo insegnante disse: “È come uno specchio luminoso, sempre liscio.”
Sembra carino, vero? Lo specchio luminoso, perfettamente liscio, riflette il tutto senza discriminazioni. Quanto è bello, quanto è bello.
Kishizawa Ian ha poi chiese: “C’è qualcosa oltre a questo?”
“Sì”, rispose il suo insegnante.
“Cosa c’è oltre questo?”
Il suo insegnante disse: “Rompi lo specchio. Vieni e ci incontriamo. “
Tenshin Reb Anderson Roshi commenta:
Quando siamo a questa fonte, seduti completamente immobili, tutti i Buddha e gli esseri senzienti sono lì con noi. Poi, in quanto vivi, questa calma esperienza dello specchio si rompe e affiorano nuvole di pensiero. A questo punto non dobbiamo pensare: “Ora devo essere compassionevole”. Il solo essere disposti a rinunciare a una grande calma e a essere nuovamente coinvolti in pensieri particolari è compassione. In questo modo rientriamo consapevolmente e volontariamente nel mondo della confusione e della sofferenza. (Wind Bell, Volume 19, No.1, Estate 1985)

Come lo facciamo penetrare nelle nostre ossa? E come usciamo consapevolmente e volontariamente dalla nostra serena bolla di calma tranquillità? Come mettiamo piede nel mondo della confusione e della sofferenza? Ci buttiamo dentro e prendiamo una Molotov e iniziamo? Forse a volte lo facciamo. E poi ci confessiamo e ci pentiamo, perché questo non aiuterà.
Tenshin Roshi continua:
Da questo punto, la compassione non è dualistica; non lo facciamo e non possiamo fermarlo. Il nostro corpo interagisce senza paura con tutte le forme di sofferenza. Ciò non significa che la paura non esista o che esista. Significa che siamo aperti a tutte le varietà di paura, in modo che le forze intorno a noi siano equilibrate. Non abbiamo più amici in paradiso di quanti ne abbiamo all’inferno.
Se abbiamo troppi amici in paradiso e non abbastanza all’inferno, allora ci sarà paura. Quindi possiamo guardare la comunità in cui viviamo. Conosciamo più persone in paradiso che all’inferno? Se lo facciamo, non siamo veramente calmi… Ogni volta che la nostra mente è completamente aperta e non controlliamo ciò a cui siamo esposti, il corpo e la mente possono stare fermi, nel cuore di tutti gli esseri sofferenti. Questo è tutto quello che dobbiamo fare. Tutto il resto si prenderà cura di se stesso.
È una dichiarazione enorme: tutto il resto si prenderà cura di se stesso. Oh, quanto è confortante, ma è un compito arduo, non è vero? Come rimaniamo con questo momento presente senza esitazione? Come apriamo il nostro cuore per sentire completamente ciò che stiamo provando, ciò che il mondo potrebbe provare? E come sviluppiamo questa capacità, come innaffiamo il seme che ha il potenziale per germogliare in un gigantesco albero di Banyan?
C’è un noto motto del Lojong: non essere così prevedibile.
Recentemente ho riscontrato una traduzione diversa dello stesso slogan, che mi ha sorpreso. Si legge: “Non fare affidamento sulla tua buona natura”. È una pratica difficile, vero? Riesco a vedere i modi in cui mi affido a ciò che considero la mia buona natura. Lo faccio ancora e ancora: è una trappola. Come fa a non diventare solo un altro tavolo che stiamo portando?
Dobbiamo porre queste domande in modo edificante. Non si tratta di vergognarsi. Come faccio a partecipare a un sistema di discriminazione razzista che è strutturale, che esiste da centinaia di anni, e in che modo traggo beneficio dal sistema? Come facciamo a porre questa domanda con speranza invece di sprofondare in una palude di inattività e disperazione, di “non posso farci niente”?

È facile cadere nel desiderio di voler aiutare, non trovando un modo conveniente e poi provare sgomento o sconforto. Come facciamo spazio anche a questo?
Come accogliamo con favore la totalità della nostra esperienza, non solo le parti che ci piacciono?
Non svilupperemo mai un sollievo allontanandoci costantemente dal nostro disagio. La nostra pratica ci chiede qualcosa di molto importante: permettere a tutto ciò che sta sorgendo in questo istante presente – non solo permetterlo, ma impegnarsi pienamente in esso, sperimentarlo, notare cosa sorge nei nostri corpi e nelle nostre menti. E darci il benvenuto. Solo allora possiamo andare avanti con l’azione saggia che deriva da quel riconoscimento. A volte potresti sentire lo Zen dire: “Non conoscere è il più intimo”. Bene, siamo chiari. Non possiamo rimanere nel non conoscere come scappatoia. Non usare “non conoscere” per non agire.
Se non vediamo che non conoscere significa anche non rimanerci, allora come possiamo aprire il nostro cuore?
Come possiamo aprire la nostra mente alla curiosità, alla meraviglia, al riconoscimento degli schemi abitudinari karmici che sono radicati nel nostro corpo e nel nostro pensiero? Sentire il peso del tavolo che portiamo sulle spalle? Non possiamo fare affidamento su questo senso di noi stessi come “bonari”. Tornando alla poesia di Mary Oliver, “Wild Geese”:
Non devi essere buono.
Non devi camminare in ginocchio
per cento miglia nel deserto in penitenza.
Devi solo lasciare quell’animale morbido del tuo corpo
amare ciò che ama.
Dimmi della tua disperazione, la tua, e io ti dirò della mia.
Mentre il mondo va avanti.
Mentre il sole e i cristalli della pioggia
girovagano per i paesaggi,
su praterie e alberi profondi,
montagne e fiumi.
Mentre le oche selvatiche, alte nel cielo blu,
volano verso casa.
Chiunque tu sia, non importa quanto sei solo,
il mondo offre se stessa alla tua immaginazione,
come le oche selvatiche ti chiama, acuto ed eccitante –
indicandoti sempre il tuo posto
nella famiglia delle cose.
Qual è l’animale morbido del nostro corpo? Il tenero animale potrebbe rannicchiarsi per la paura, cercando di trovare un posto dove nascondersi. Il tenero animale potrebbe mostrare i denti, pronto a mordere alla prima provocazione. L’animale tenero potrebbe sistemarsi per la notte, sentendosi contento e a suo agio. Come facciamo a fare spazio all’animale morbido in noi piuttosto che a quello che a volte facciamo, che è esiliare l’animale morbido se non ci piace quello che prova? Oliver dice: “Parlami della disperazione, la tua, e io ti dirò la mia”; ed è questa sofferenza umana che connette tutti noi. È proprio lì.
Ma poi c’è la riga successiva: “Nel frattempo il mondo va avanti”. Il mondo va avanti tra il virus, il clima e l’ingiustizia – tutta quella sofferenza, tutte le incognite, eppure il mondo va avanti.
Come teniamo tutto ciò nel nostro cuore?
Se decidiamo di unirci a una protesta nella nostra città, o se non lo facciamo, come lo teniamo nel nostro cuore? Come restiamo in contatto con il nostro animale tenero e ciò che ci dice, ciò che ama, ciò di cui ha paura, ciò di cui ha bisogno, ciò che desidera, ciò che lo nutre? Forse c’è una parte in noi che non vuole tenerlo – come lo mettiamo?
Quando siamo a nostro agio, la nostra vera natura di consapevolezza aperta può farsi avanti. Quando siamo soffocati e spaventati, dobbiamo trovare agio nel soffocamento e nella paura. Possiamo fare quel passo indietro – possiamo sempre, sempre, anche se è solo un po ‘, anche se si tratta solo di piantare un minuscolo seme di una domanda che chiede: “come faccio ad accettare questa paura? Come la affronto?”
Possiamo iniziare con la sensazione di spazio prendendo un respiro. Se questo non funziona, possiamo forse trovare agio nella nostra vista: possiamo guardare qualcosa di spazioso, come il cielo o l’acqua, e respirarci dentro, trovandoci un po’ di tranquillità.
I nostri migliori sé non avanzano da luoghi di soffocamento. Ci prendiamo una pausa e invitiamo un po’ di agio nel soffocamento prima di agire. Troviamo compassione, anche quando è difficile. Questa è la sfida della pratica e ciò dura tutta la nostra vita. Oltre il mio dukkha, il tuo dukkha.

Doshin Mako Voelkel
Doshin Mako Voelkel ha iniziato la pratica Zen al San Franciso Zen Center, dopo aver praticato la meditazione trascendentale per più di un decennio. Nel 2002 ha lasciato il suo posto di insegnante di filosofia al City College di San Francisco per praticare a Tassajara, dove è rimasta per dieci anni, fino a diventare un’allieva di Ryushin Paul Haller. Ora è preside dell’Austin Zen Center.
Questo articolo è stato pubblicato il 14 ottobre su Lion’s Roar.