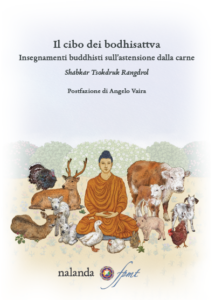Prima di approfondire questo argomento, penso sia utile fare il punto su ciò che già sappiamo. Se pensiamo alle storie tradizionali raccontate nel Buddhismo, come e quando compaiono le donne? Qual è il loro significato nella vita del Buddha? Qual era la cultura e il clima sociale del suo tempo? Come è possibile applicare quelle storie, oggi, nella nostra pratica?
Iniziamo dalla madre del Buddha. Sappiamo bene che nel buddhismo la figura materna è celebrata come il più alto esempio mondano di amore e gentilezza. Rivisiteremo più avanti questa idea dell’archetipo della madre, ma per ora concentriamoci soltanto sulla madre storica del Buddha.
La vita del Buddha e la sua illuminazione possono essere analizzate da molte angolazioni diverse.
Dal punto di vista della tradizione Pāli e di quella sanscrita, i fatti vengono presentati in modi leggermente diversi. Tradizioni diverse sottolineano aspetti diversi, ma qui farò riferimento solo ai punti salienti condivisi da tutti.
Prima ancora che il Buddha nascesse, sua madre – Māyā (o Mahāmāyā), descritta come donna di grande bellezza – ebbe un sogno premonitore. Ciò dovrebbe dirci che, con tutta probabilità, era un essere con grandi realizzazioni, dotata di una sorta di chiaroveggenza che le permise di vedere chi era destinato a diventare il bambino che portava in grembo. Poco dopo il parto, Māyā morì e di lui si prese cura la sorella di lei, Prajapati, divenuta la nuova consorte del re Suddhodana. Queste sono le prime due figure femminili di cui sentiamo abitualmente parlare.
In questa storia sono coinvolti anche numerosi uomini e in ruoli diversi, ma le donne menzionate fin qui sono madri, figure potenti e significative, contestualizzate in quel ruolo.
Il tempo passa e Siddharta cresce. Se è ancora solo un principe oppure è già un Buddha dipende dalle tradizione ma, in ogni caso, a un certo punto si sposa con Yoshodara con la quale, si dice, ebbe molte relazioni in molte vite precedenti.
Come usanza dell’epoca, fu più un matrimonio combinato che un matrimonio d’amore e non sappiamo molto altro del loro rapporto. Non sappiamo come si è sentita Yoshodara quando Siddharta se ne andò di casa, non sappiamo come si sentì per essere stata abbandonata con il loro bambino, né come vivesse la presenza delle molte concubine del marito. Sappiamo però che è esistita come figura storica, trasformata però nell’archetipo della “fanciulla” che diventa “madre”. A quanto pare e nonostante tutto, i suoi rapporti con il Buddha rimasero buoni, tanto che dopo la sua illuminazione, lei stessa divenne una sua seguace. Che abbia provato o meno rabbia e rancore verso il marito, il loro legame non si interruppe mai.
La storia del Buddha prosegue dunque con l’abbandono del palazzo reale, la vita ascetica, l’incontro con i cinque meditatori… una parte di narrazione che conosciamo piuttosto bene. La prossima donna di cui sentiamo parlare è la ragazza che offrì a Siddharta del cibo, subito dopo che egli ebbe compreso che una vita di assoluta deprivazione non era il giusto cammino spirituale e stava per imboccare in sentiero della via di mezzo.
Prima di incontrare quella ragazza, il Buddha aveva vissuto sei o sette anni di austerità, senza mangiare né bere, assorto in rigorosa meditazione, rispettando le pratiche molto severe della tradizione indù. Rafforzando sì la sua rinuncia al mondo, ma spingendosi un po’ troppo oltre.
Del momento in cui si rese conto degli eccessi dell’ascetismo estremo vi sono molte storie popolari.
La versione più comune è che il Buddha, a un certo punto, sentì un insegnante di musica spiegare a un suo studenteche “se le corde dello strumento troppo tese, si spezzeranno; se sono troppo lasche, non emettono alcun suono”. Spesso questo è indicato come il momento chiave in cui il Buddha decise di cambiare il suo modo di praticare.
E è proprio allora che appare – dal nulla, da un villaggio, chi lo sa? – la ragazza che gli offre il primo cibo nutriente e sostanzioso dopo molti anni. Grazie a quel pasto, Siddharta recuperò le forze, ritornò a meditare e finalmente raggiunse l’illuminazione.
Nella storia del Buddha che ascoltate nei centri di Dharma, queste sono le quattro donne di cui sentite parlare. Ma se si scava un po’ più a fondo, se ne possono trovare altre, ma abitualmente queste sono le uniche di avrete notizia.
Prajapati, la zia e matrigna del Buddha, è per noi (monache, ndt) molto importante perché è stata la prima a ricevere l’ordinazione monastica, dopo non poche discussioni e dibattiti sull’opportunità o meno di concedere anche alle donne questa opportunità. Si trattava di un tema culturalmente rilevante all’epoca: quanto era pericoloso per le donne viaggiare e muoversi di villaggio in villaggio da sole? Quanto era controverso il fatto che decidessero di non avere, o di abbandonare, la propria famiglia?
Prajapati si rivelò estremamente coraggiosa e determinata nel fare al Buddha una richiesta di quella portata, con tutte le implicazioni che avrebbe comportato. I monaci ne discussero veramente a lungo, finché il Buddha – finalmente – affermò che uomini e donne sono uguali e che il loro potenziale per l’illuminazione è identico.
Questo è un fatto storico, non un mito o una leggenda. Il Buddha fu incredibilmente progressista: non solo sosteneva che il sistema delle caste era un’assurdità, ma che altrettanto lo fosse il sessismo. Nei suoi discorsi ha affrontato temi come l’economia, il razzismo e il genere con molta più libertà della maggior parte degli insegnanti del suo tempo.
Che io possa non rinascere mai come donna
Nonostante il resoconto dell’ordinazione di Prajapati, e la conseguente istituzione di un Sangha femminile, sia una versione della storia universalmente accettata, in molte culture in cui il buddhismo si è diffuso viene completamente omessa. Ci sono scuole, all’interno del buddhismo, secondo le quali si ritiene sia meglio essere un uomo. E ciò avviene a causa di un’incomprensione di alcuni aspetti dei Sutra. Anche nella nostra tradizione (il buddhismo tibetano, erede della tradizione del Nalanda, ndt) ci sono tre Sutra, che recitiamo molto spesso, che potrebbero indurre a questo malinteso: il Sutra della Luce Dorata, il Sutra del Diamante e il Sutra di Lunga Vita “Tse Dö”. Ma ve ne sono molti altri Sutra in cui si legge questa invocazione “attraverso il potere derivante dalla recitazione di questo Sutra, che io possa non rinascere mai come donna”.
Quando si arriva a questa frase, le donne di solito non la prendono benissimo, mentre per alcuni uomini diventa un’ottima scusa per avere di loro una scarsa considerazione. Ma il punto è che quell’affermazione non è quello che sembra.
Quell’invocazione, di fatto, chiede di ottenere sempre le condizioni più favorevoli alla pratica del Dharma.
Essere donna non è mai stato facile: ogni cultura ha imposto condizionamenti e restrizioni sociali, meno opportunità di istruzione, ruoli prestabiliti, primo fra tutti quello di moglie e madre. Sappiamo che, in teoria, avere figli si rivela essere anche un’opportunità straordinaria per sviluppare la compassione, l’amorevole gentilezza, la pazienza… chiunque ha dei figli o si prende cura dei bambini lo sa bene, così come sa che i piccoli sono una costante fonte di distrazione per cui si hanno sì molte opportunità per praticare, ma pochissime per studiare.
Quindi, augurarsi di non rinascere mai come donna significa in buona sostanza desiderare di ottenere le circostanze e le condizioni più favorevoli per studio e la pratica: essere liberi di muoversi senza correre rischi, non doversi prendere cura della famiglia e dei figli, avere accesso all’istruzione, avere tempo per meditare e fare ritiri, non avere distrazioni dettate dalle incombenze generalmente attribuite al ruolo femminile.
Il problema quindi non è rinascere donna, caso mai è sempre stato – ed è ancora – la mentalità patriarcale e il modo di pensare di certi uomini. Una cultura che rafforza questi atteggiamenti negativi danneggia anche gli uomini. Ma è importante conoscere il contesto culturale e sociale in cui i Sutra citati furono trasmessi per la prima volta.
Quando leggiamo quei testi, dobbiamo allora ricordare non solo il momento storico in cui sono stati scritti, ma anche che tutti gli insegnamenti – ad eccezione di quelli sulla vacuità – devono essere interpretati, hanno un significato provvisorio che deve essere scandagliato attraverso la logica e la saggezza.
È importante accostarsi con oggettività agli insegnamenti e metterli sempre a confronto con la nostra esperienza di vita e la nostra logica. Soprattutto, dobbiamo tornare sempre ai principi fondamentali e il fondamento di ogni pratica è l’etica.
Il fondamento dell’etica
Etica significa non causare danno, non fare del male. Quindi, se le pratiche sono dannose, non sono etiche. Alcune restrizioni che in passato avrebbero potuto proteggere le donne, ora possono essere viste come obsolete, limitative, se non addirittura dannose. E’ importante che il Dharma sia in linea con la morale sociale del tempo.
Dobbiamo mantenere vivo il dibattito su questi temi e non lasciare che le tradizioni diventino una routine accettata acriticamente: potrebbero esserci dei significati più profondi che ci siamo persi.
Se poi ci addentriamo nel buddismo tibetano, c’è ancora di più lavoro da fare. Qual è la percentuale di figure femminili sui nostri altari rispetto a quelle maschili? ((Nel Centro FPMT in cui si è tenuta questa conferenza era del 2%, una percentuale non dissimile alla quella della maggior parte degli altari dei Centri buddhisti tibetani))
Non è una domande pretestuosa. Si tratta di una questione culturalmente rilevante, storicamente rilevante e ancora un po’ problematica. Perché ora esistono anche le foto, e non solo le thangka, ma continuano ad essere immagini per lo più di uomini. Sono tutti uomini.
Siamo seduti in un centro di Dharma, ci guardiamo intorno e ci chiediamo: chi sono le persone che frequentano e hanno frequentato i centri, in Occidente, negli ultimi cinquant’anni? Soprattutto donne.
E’ una discussione importante, da affrontare con compassione e saggezza, ma ormai ineludibile. Certo, i nostri insegnanti sono stati educati soprattutto all’interno del sistema monastico e il sistema monastico è profondamente sessista. Possiamo dirlo. Non c’è niente di male nell’affermarlo. E dovremmo ripetercelo spesso. Ciò non significa che i nostri geshe non sono preparati. Lo sono di certo. Ma sono più istruiti perché hanno avuto più opportunità di studiare di quante storicamente siano state concesse alle donne. Ha senso?
Se nei Centri siete abituati a vedere sempre e solo uomini nelle posizioni di potere, questa a poco a poco diventa la vostra “normalità”. E se i maestri più illustri sono il più delle volte tibetani, anche questo diventa “normale”. Capita frequentemente anche una cosa abbastanza strana: un geshe occidentale, inconsciamente ci sembra meno speciale di uno himalayano. Hanno la stessa formazione e preparazione, ma c’è meno “magia”. In più parla la vostra stessa lingua, il che è noioso e meno “magico”.
Dobbiamo riconoscere questa nostra curiosa forma di razzismo e allo stesso tempo ricordarci che, poiché il buddhismo esiste in Tibet e in India da molti più anni che qui, è logico che esista un numero maggiore di insegnanti orientali rispetto agli occidentali. Ma dobbiamo interrompere la nostra associazione mentale che presuppone che il tibetano sia a priori un santo. Se avrete l’opportunità di vivere a Dharamsala per un po’ di tempo, questo incantesimo certamente svanirà.
Quando si pratica il buddhismo tibetano, soprattutto all’inizio, è facile pensare che i tibetani siano un popolo speciale, tutti mistica in carne ed ossa, intrinsecamente più etici e più gentili di chiunque altro al mondo. Molti di loro effettivamente lo sono, provenendo da una cultura intrisa di buddhismo da così tanti secoli, ma questo non significa che tutti abbiano studiato, praticato o addirittura compreso il buddhismo.
La cornice etica della cultura tibetana ha tutt’ora componenti da cui dovremmo guardarci, mentre ci sono aspetti della nostra da cui potrebbero davvero imparare, come l’uguaglianza di genere.
Ed è importante che i generi all’interno del “pensiero buddhista” si parlino, con gentilezza e rispetto. Ma dobbiamo parlare: gli uomini dovrebbero dirci come ci si sente ad essere circondati da così tante donne. Abbiamo bisogno di sapere com’è per loro vivere in un modo buddhista in un mondo molto poco compassionevole, quanto può essere difficile adottare ideali come la compassione e la gentilezza amorevole in una cultura che esalta i “macho” e i maschi alfa.
Poi però dobbiamo anche domandarci perché, per esempio, in un incontro di Dharma di una cinquantina persone, dove solo quattro o cinque sono uomini, sono quasi sempre sono questi ultimi a fare delle domande? Un singolo uomo può dominare un’intera discussione perché la società lo ha incoraggiato a farsi sentire, ad essere a proprio agio con le proprie opinioni e a discutere senza vergogna.
Certo, gli uomini possono porre ottime domande durante una discussione di di Dharma, ma potrebbero non rendersi conto di essere gli unici a prendere la parola e neppure chiedersene la ragione; potrebbero non sapere che se loro non ci fossero, l’intera dinamica dell’incontro cambierebbe perché il sessismo interiorizzato delle donne si rilassa quando “siamo solo tra ragazze”. Non è colpa di nessuno, è semplicemente come è stata costruita la società.
Siamo solo “uomini” e “donne”, etichettati semplicemente dalla mente. Siamo stati tutti innumerevoli volte qualsiasi tipo di espressione di genere. L’eccessiva identificazione con qualsiasi parte della propria identità, compresa quella sessuale, è un’esagerazione, è un sintomo del nostro attaccamento all’idea di esistenza intrinseca. Abbiamo tuttavia bisogno di conciliare questa comprensione filosofica con la nostra esperienza quotidiana del genere a cui apparteniamo.
Penso che affrontare questi argomenti possa arricchire molto la nostra pratica. Ma c’è ancora il problema, o l’opportunità, di trovarci ancora sotto l’ombrello della cultura tibetana, che è molto indietro rispetto alla comprensione di base della biologia o della storia. Dobbiamo rompere l’incantesimo di pensare che i tibetani e altre culture himalayane siano “magici”. Il buddhismo è incredibile. La cultura tibetana l’ha preservato splendidamente e noi gliene siamo grati. Ma la combinazione tra questa antica tradizione e il mondo moderno sta diventando sempre più problematica.
La struttura gerarchica del buddhismo tibetano sta diventando sempre più corrotta. Abbiamo insegnanti sorprendenti, come Sua Santità il Dalai Lama, che hanno un’etica perfetta, ma non dovremmo presumere che tutti i lama siano così. Dobbiamo sempre mantenere il nostro buon senso e prendere ogni individuo per quello che è: valutare con una mente veramente aperta, con rispetto per la sua educazione e i suoi voti, ma guardare lucidamente l’essere umano che sta al centro di tutto questo. Praticano tutti ciò che insegnano?
Il Dharma è vasto e profondo, ma potreste ascoltarlo da un leader carismatico e ben istruito con un’etica terribile. Il modo tibetano di praticare il Buddhismo ha alcune tendenze tipiche dei culti: la devozione al guru è fortemente incentivata e promossa. Al contrario, la pratica di indagare in maniera approfondita e a lungo un insegnante prima instaurare una relazione guru-discepolo – secondo le raccomandazioni del Buddha stesso – è meno diffusa. Quindi dobbiamo rimanere aperti e scettici.
È bene essere veramente pronti ad accettare gli insegnamenti, ad applicarli come consiglio personale. Tuttavia, non bisogna non lanciarsi in un rapporto guru-discepolo con chiunque, solo per la sua notorietà.
Se sentite la parola “geshe”, il suo significato è “ben istruito”, non “perfettamente virtuoso”. La maggior parte dei geshe è virtuosa, ma non tutti. Essere un geshe non è di per sé una garanzia di perfetta condotta etica.
Se sentite la parola “Rinpoce”, sappiate che questo appellativo può essere stato attribuito per ragioni molto diverse. A volte perché la persona è stata riconosciuta come un essere realizzato; a volte quel “riconoscimento” è stato acquistato, per esempio da una famiglia facoltosa con una buona reputazione; altre volte viene chiamato “Rinpoce” chi ha condotto una vita di lavoro positiva; può essere anche un titolo onorifico, conferito dopo che qualcuno è stato abate di un grande monastero. Ma se sentiamo “Rinpoce”, non dobbiamo necessariamente tradurlo come “affidabile”. Siate aperti e scettici.
C’è stato un periodo della mia vita in cui pensavo: “Non posso dire cose come questa in pubblico! La gente perderà la fiducia nel buddhismo tibetano! E se si rendessero conto che le organizzazioni sono fatte di gente comune e che, come ogni singola religione organizzata, c’è burocrazia e corruzione anche qui? Se non capissero che facciamo il meglio che possiamo, ma che ci sono anche le nostre afflizioni mentali?
Oggi non ho più paura di parlare così apertamente perché il Buddismo è abbastanza forte per affrontare la verità. La saggezza del Buddismo è abbastanza forte da resistere a qualsiasi esame.