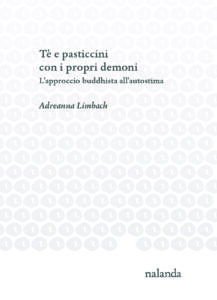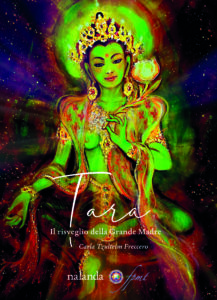La società moderna sembra essere ossessionata dalla ricerca della felicità, ma secondo alcuni filosofi, questa potrebbe essere una ricerca vana.
“La felicità è un’emozione legata al miglioramento della salute e del benessere, ma la nostra ossessione di essere felici è una ricetta per la delusione?”, chiede Nat Rutherford.
Cosa vuoi dalla vita? Probabilmente di recente hai avuto l’opportunità e i motivi per porti questa domanda. Forse vuoi trascorrere più tempo con la tua famiglia, ottenere un lavoro più soddisfacente e sicuro, oppure migliorare la tua salute. Ma perché desideri queste cose?
È probabile che la tua risposta si riduca a una parola: felicità. La fissazione della nostra cultura per la felicità può sembrare quasi religiosa. È una delle uniche ragioni per agire che non ha bisogno di giustificazione: la felicità è buona, perché essere felici è buono. Ma possiamo costruire le nostre vite su quel ragionamento circolare?

Considerando l’importanza della domanda, ci sono pochi dati su ciò che le persone vogliono dalla vita. Un sondaggio nel 2016 ha chiesto agli americani se preferissero “ottenere grandi cose o essere felici”. L’81% ha risposto che avrebbe preferito essere felice, mentre solo il 13% ha optato per ottenere grandi cose (il 6% era comprensibilmente scoraggiato dalla scelta e non era sicuro).
Nonostante l’ubiquità della felicità come obiettivo, è difficile sapere come definirla o come raggiungerla.
Tuttavia, sempre più aspetti della vita vengono giudicati in base al loro contributo a concretizzare il fantasma della felicità. La tua relazione, il tuo lavoro, la tua casa, il tuo corpo, la tua dieta ti rendono felice? In caso contrario, stai facendo qualcosa di sbagliato?
Nel nostro mondo contemporaneo, la felicità è la cosa più vicina a un summum bonum, un bene supremo da cui fluiscono tutti gli altri beni. In questa logica, l’infelicità diventa il summum malum, il male più grande da evitare. Eppure ci sono prove per cui la ricerca ossessiva della felicità si associa a un maggior rischio di depressione.

Nel suo recente libro, The Enlightenment: The Pursuit of Happiness, lo storico Ritchie Robertson sostiene che l’Illuminismo dovrebbe essere inteso non come l’aumento del valore della ragione stessa, ma invece come la ricerca della felicità attraverso la ragione.
La forza intellettuale determinante della modernità riguardava la felicità e ancora oggi siamo alle prese con i limiti di quel progetto.
È facile presumere che la felicità sia sempre stata valutata come il bene supremo, ma i valori e le emozioni umane non sono definiti in modo permanente. Alcuni valori che una volta erano preminenti, come l’onore o la pietà, hanno perso importanza, mentre emozioni come “accidia” (immobilità, un’apatia che ci porta a non agire) sono scomparse completamente.
Sia il linguaggio che usiamo per descrivere i nostri valori ed emozioni, sia gli stessi sentimenti sono instabili.
Le moderne concezioni della felicità sono principalmente pratiche e non filosofiche, e si concentrano su qualcosa che potremmo chiamare le tecniche della felicità. La preoccupazione non è cosa sia la felicità, ma piuttosto come ottenerla. Tendiamo a vedere la felicità in termini medicalizzati come l’opposto della tristezza o della depressione, il che implica che la felicità emerge dalle reazioni chimiche nel cervello. Essere felici significa avere meno reazioni chimiche che ti rendono triste e più reazioni che ti rendono felice.

“Le società moderne considerano la felicità come il nome di un sentimento di appagamento o di piacere, e si presume che una visione che fa della felicità il bene supremo sia, per definizione, una visione che dà valore supremo a stati psicologici”.
Martha Nussbaum, eminente filosofa sostenitrice della teoria “Neo-stoica” delle emozioni.
I libri di auto-aiuto e la psicologia positiva promettono di sbloccare quello stato psicologico o l’umore felice. Ma i filosofi hanno avuto la tendenza a essere scettici su questa visione della felicità, perché i nostri stati d’animo sono fugaci e le loro cause incerte.
Invece, pongono una domanda correlata ma più ampia: cos’è la bella vita?
Una risposta potrebbe essere una vita spesa a fare cose che ti piacciono e che ti danno piacere. Una vita spesa a provare piacere sarebbe, in qualche modo, una bella vita. Ma massimizzare il piacere non è l’unica opzione.
Ogni vita umana, anche la più fortunata, è piena di sofferenza. Perdite dolorose, delusioni cocenti, sofferenza fisica dovuta a lesioni o malattie, sofferenza mentale dovuta alla noia… Fino alla solitudine o alla tristezza persistenti. La sofferenza è una conseguenza inevitabile dell’essere vivi.
Per l’antico filosofo greco Epicuro (341-270 a.C.), una buona vita è quella in cui la sofferenza è ridotta al minimo. La prolungata assenza di sofferenza ci garantisce la tranquillità della mente, o atarassia.
Questa nozione ha qualcosa in comune con la nostra moderna concezione della felicità.
Essere “in pace con te stesso” distingue la persona felice da una infelice e nessuno immaginerebbe che una vita piena di sofferenza possa essere una bella vita. Ma la riduzione al minimo della sofferenza è davvero l’essenza della felicità?
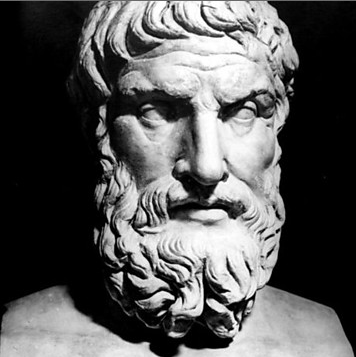
E se vivere una buona vita aumentasse la sofferenza che proviamo? Gli studi hanno dimostrato che avere attaccamenti amorevoli è correlato alla felicità, ma sappiamo per esperienza che l’amore è anche la causa di sofferenza. E se la sofferenza fosse necessaria e persino desiderabile?
La dolorosa morte di genitori, figli, partner o amici potrebbe essere ovviata smettendo di prendersi cura di quelle persone o escludendole completamente dalla tua vita. Ma una vita senza attaccamenti amorevoli è carente sotto aspetti importanti, anche se potrebbe liberarci dalla sofferenza lacerante di perdere coloro che ami. Meno drammaticamente, tutte le cose buone della vita comportano sofferenza. Scrivere un romanzo, correre una maratona o partorire causano sofferenza durante la ricerca del risultato finale e gioioso.
La felicità epicurea è questione di essere un buon contabile e di ridurre al minimo la sofferenza nel modo più efficiente possibile
Epicuro potrebbe rispondere che l’inevitabilità della sofferenza rende effettivamente l’atarassia più attraente. Accettare l’inevitabile, cercando di minimizzarne il danno, è l’unico modo per vivere. Puoi anche utilizzare la riduzione della sofferenza come guida all’azione. Se il processo di scrittura di un romanzo ti causa più sofferenza che piacere che ti aspetti dal finirlo, allora non scriverlo.
Ma se un po’ di dolore ora previene un dolore maggiore in seguito – il dolore di smettere di fumare per evitare il dolore del cancro, per esempio – allora quel dolore può probabilmente essere giustificato. La felicità epicurea è questione di essere un buon contabile e di ridurre al minimo la sofferenza nel modo più efficiente possibile.

Tuttavia, la visione della felicità del contabile è troppo semplice per riflettere la realtà. Friedrich Nietzsche, in Genealogia della Morale, ha visto che non sopportiamo semplicemente la sofferenza come mezzo per un maggiore piacere.
L’uomo […] non ripudia la sofferenza in quanto tale. La desidera, la cerca, purché gli venga mostrato un significato per esso, uno scopo di sofferenza.
Friedrich Nietzsche
Secondo Nietzsche, il dolore non è alleviato dal piacere, ma piuttosto dal significato.
Era scettico sul fatto che avremmo potuto trovare un significato sufficiente per rendere la sofferenza degna di essere vissuta, ma la sua intuizione indica il difetto nella visione di Epicuro della bella vita.
Una vita di dolore significativo, quindi, potrebbe essere più preziosa di una vita di piacere senza senso. Come se non fosse già abbastanza difficile capire cos’è la felicità, ora abbiamo bisogno di capire cos’è anche una vita significativa.
Ma se mettiamo da parte la domanda spinosa di ciò che rende la vita significativa, possiamo ancora vedere che la visione moderna della felicità come summum bonum – o bene supremo da cui fluiscono tutti gli altri beni – è sbagliata.
Il filosofo americano Robert Nozick ha escogitato un esperimento mentale per chiarire il punto. Nozick ci chiede di immaginare una macchina che possa darci l’esperienza che desideriamo.
La macchina ci permetterebbe di sperimentare la gioia di soddisfare ogni nostro desiderio. Potremmo essere grandi poeti, diventare il più grande inventore mai conosciuto, viaggiare per l’Universo su un’astronave di nostra creazione o diventare uno chef benvoluto in un ristorante locale. In realtà, però, saremmo incoscienti in una vasca di supporto vitale. Poiché la macchina ci farebbe credere che la simulazione sia reale, la nostra scelta sarebbe definitiva.
Tu ti collegheresti? Nozick dice che non lo faresti, perché vogliamo effettivamente fare certe cose ed essere certe persone, non solo avere esperienze piacevoli. Questa situazione ipotetica potrebbe sembrare frivola, ma se siamo disposti a sacrificare un piacere illimitato per un significato reale, la felicità non è il bene supremo.
Ma se Nozick ha ragione, allora l’81% degli americani intervistati che ha scelto la felicità piuttosto che grandi risultati, ha torto. Infatti gli studi hanno dimostrato che le persone sceglierebbero per lo più di non entrare nella macchina.
La macchina dell’esperienza di Nozick mirava a confutare l’affermazione essenziale dell’utilitarismo.
La teoria dell’utilitarismo sostiene che la felicità è desiderabile, anzi che è l’unica cosa desiderabile come scopo nella vita. Nel 1826, il filosofo che scrisse quelle parole, John Stuart Mill, rimase impantanato nell’infelicità. Nella sua autobiografia, Mill descrive ciò che ora riconosciamo come anedonia depressiva:
“Ero in uno stato di nervi ottusi, come tutti ne sono occasionalmente soggetti. Insensibile al divertimento o all’eccitazione piacevole, uno di quegli stati d’animo in cui ciò che in altri momenti è piacere diventa insipido o indifferente.
John Stuart Mill
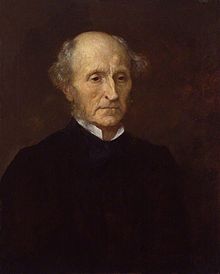
Mill non poteva trarre piacere dalla vita. Questo sarebbe un male per la maggior parte delle persone, ma per Mill indicava qualcosa di ancora più preoccupante. Gli era stato insegnato dalla nascita che il fine ultimo della vita è massimizzare il piacere dell’umanità e minimizzarne la sofferenza.
Il padre di Mill era un seguace del filosofo utilitarista classico Jeremy Bentham, e aveva cresciuto suo figlio secondo le opinioni di Bentham. Bentham andò oltre Epicuro, facendo della felicità l’attrazione ultima di una vita individuale e l’attrazione ultima della moralità. Per Bentham, tutte le questioni morali, politiche e personali possono essere risolte da un semplice principio: la più grande felicità per il maggior numero di persone. Ma se quello era l’unico principio in base al quale vivere, come poteva Mill giustificare la propria esistenza, priva com’era di felicità?
A differenza della felicità, l’eudemonia si realizza attraverso abitudini e azioni, non attraverso stati mentali.
Attraverso la sua depressione, Mill si rese conto che il punto di vista utilitaristico di Bentham, che elevava il piacere al bene supremo, era una “filosofia suina”, adatta solo ai maiali. Insoddisfazione, infelicità e sofferenza fanno parte della condizione umana e quindi “è meglio essere un essere umano insoddisfatto che un maiale soddisfatto”, secondo Mill. Ha continuato a credere che la felicità fosse profondamente importante, ma si è reso conto che mirare alla felicità raramente porta ad essa.
Invece, Mill pensava che dovresti mirare ad altri beni, e la felicità potrebbe essere un felice sottoprodotto. Ma questo suggerisce anche che una buona vita può essere infelice. Ciò che Mill riconosceva era ciò che Aristotele aveva sostenuto due millenni prima: il piacere passeggero della felicità è secondario al vivere una buona vita, o al raggiungimento di ciò che Aristotele chiamava Eudaimonìa.

L’eudemonia è difficile da tradurre nei nostri concetti contemporanei.
Alcuni, come la filosofa Julia Annas, la traducono direttamente come “felicità”, mentre altri studiosi preferiscono “fioritura umana”. Qualunque sia la traduzione, segna un netto contrasto con la nostra moderna concezione della felicità.
La visione di Aristotele della prosperità è complessa e complicata perché incorpora soddisfazione individuale, virtù morale, eccellenza, buona fortuna e impegno politico. A differenza della visione contabile della sofferenza di Epicuro o della visione “suina” del piacere di Bentham, l’idea di prosperità di Aristotele è disordinata come gli umani che descrive.
Come la nostra moderna concezione della felicità, l’eudemonia è lo scopo ultimo della vita. Ma a differenza della felicità, l’eudaimonia si realizza attraverso abitudini e azioni, non attraverso stati mentali. La felicità non è qualcosa che provi o ottieni, è qualcosa che fai.
Nella sua Etica Nicomachea, Aristotele scrive: “Poiché non è una rondine o una bella giornata che fa la primavera, così non è un giorno o un breve periodo che rende un uomo benedetto e felice”. In altre parole, prosperare è l’impresa di una vita perché è qualcosa che devi coltivare quotidianamente attraverso le tue azioni. Come gli utilitaristi, Aristotele sosteneva che la felicità e la virtù erano inestricabilmente legate.

Per Aristotele, la virtù è una caratteristica che raggiunge una posizione media o centrale tra gli estremi.
Ad esempio, tra gli estremi della codardia e della follia c’è il coraggio, tra gli estremi dell’avaro e dello spendaccione c’è la generosità. Agire in modo da mantenere un equilibrio tra gli estremi è un’azione virtuosa. Ma dove gli utilitaristi riducevano la moralità alla felicità, Aristotele riteneva che la virtù fosse necessaria ma non sufficiente per l’eudemonia. Non possiamo prosperare senza virtuosismi, ma l’essere virtuosi non è nemmeno una scorciatoia per l’eudemonia. Piuttosto, l’azione virtuosa è essa stessa una parte dell’eudemonia.
Aristotele sosteneva che le domande su cosa rende felice qualcuno e cosa rende qualcuno una brava persona non sono separate. Il rapporto tra la bontà etica e il vivere una buona vita era, afferma Anna, la questione determinante della filosofia antica. Ed è ancora la nostra domanda oggi.
La felicità non è uno stato emotivo tanto quanto è l’eccellenza delle relazioni che coltiviamo con le altre persone

Per Aristotele, prosperiamo esercitando le nostre capacità unicamente umane di pensare e ragionare. Ma pensare e ragionare sono attività tanto sociali quanto individuali: “gli uomini non sono individui isolati, e le eccellenze umane non possono essere praticate dagli eremiti”. Se la prosperità richiede altri, allora anche la felicità. La felicità non è uno stato emotivo tanto quanto è l’eccellenza delle relazioni che coltiviamo con le altre persone.
Ma anche questo non può garantire la prosperità. Aristotele ha riconosciuto che la nostra felicità è ostaggio della fortuna. Eventi al di fuori del controllo di qualsiasi individuo – guerra, amore non corrisposto, povertà e pandemie globali – spesso renderanno impossibile lo sviluppo (e la felicità con esso).
Questa idea di fortuna morale non mina la ricerca dell’eudemonia anche quando la colpisce. La felicità non è uno stato mentale che può essere conquistato in modo permanente, ma è invece una pratica che perfezioniamo, imperfettamente, in circostanze solo in parte di nostra creazione.
Riconoscere questo non garantirà una buona vita, ma dissiperà l’illusoria speranza di eterna contentezza. Fraintendendo la felicità, la concezione moderna aumenta la probabilità di delusione. Nessuna vita degna di essere vissuta dovrebbe soddisfare lo standard stabilito dalle visioni epicuree o utilitaristiche della felicità, e quindi i suoi moderni aderenti sono destinati a essere disillusi dai difetti della vita umana. Invece, mira con Aristotele ad abbracciare quelle imperfezioni e a prosperare nonostante esse.

Nat Rutherford
Nat Rutherford insegna teoria politica presso la Royal Holloway, University of London. Ha conseguito il Dottorato in Filosofia e Politica nel 2018 con una tesi su “Moral Pluralism and Political Disagreement” (pluralismo morale e disaccordo politico).